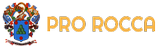PANORAMICHE
la Chiesa
la Chiesa
Quella che fu l'antica fortezza d'Obizzo
Panoramiche
La Rocca del Pelago
La Chiesa
Dedicata a S. Paolo Apostolo sorse dai resti del castello nel 1585
ORIGINE DELLA CHIESA DI ROCCAPELAGO
L'origine della chiesa di Roccapelago si presenta come un intricato problema alla cui soluzione ha atteso con buona volontà lo storico Bernardino Ricci.
Adriano Gimorri vede il primo missionario venuto fra i monti del Pelago ad annunziare il vangelo di Cristo. Donde veniva quell'ignoto apostolo?
Mons. Pistoni in un suo recente studio sull'origine e la diffusione del Cristianesimo nell'Alto Frignano ,non esita ad affermare che il vangelo fu irradiato nel Pelago da missionari provenienti da Modena e ciò fin dal III e IV secolo. La fiamma della fede splendette innanzi tutto dove poi sorse la Chiesa madre, la Pieve del Pelago. Flamignatico fu rasa al suolo nella guerra combattuta fra i Lucchesi ed Obizzo da Montegarullo e in sua vece sorse Groppo. Riolunato, Tagliole e S. Anna acquisteranno una collocazione ecclesiale soltanto nel sec. XVII.
Adriano Gimorri vede il primo missionario venuto fra i monti del Pelago ad annunziare il vangelo di Cristo. Donde veniva quell'ignoto apostolo?
Mons. Pistoni in un suo recente studio sull'origine e la diffusione del Cristianesimo nell'Alto Frignano ,non esita ad affermare che il vangelo fu irradiato nel Pelago da missionari provenienti da Modena e ciò fin dal III e IV secolo. La fiamma della fede splendette innanzi tutto dove poi sorse la Chiesa madre, la Pieve del Pelago. Flamignatico fu rasa al suolo nella guerra combattuta fra i Lucchesi ed Obizzo da Montegarullo e in sua vece sorse Groppo. Riolunato, Tagliole e S. Anna acquisteranno una collocazione ecclesiale soltanto nel sec. XVII.
Resta il mistero di Roccapelago, assente in quell'elenco, nonostante la sua antica origine, e che non figura nemmeno nel giuramento prestato dalle chiese del Pelago a Modena nel 1197. Come spiegare la stranezza del fatto?
Il Ricci avanza un'ipotesi che il Santini avalla e sviluppa. Il Castrum menzionato nel documento d'Astolfo avrebbe abbracciato due poli distinti: il polo ecclesiastico gravitante su Pievepelago, sede della chiesa madre, e il polo politico amministrativo incentrato in Roccapelago, sede del Castrum feudale. L'assenza di Rocca fra le capellae del Pelago denota che essa ecclesiasticamente era incorporata nella Pieve.
È probabile che vi sorgesse una cappella feudale dedicata a S. Paolo, la quale formera il nucleo della futura parrocchia, ma i cataloghi non la menzionano, per quanto risulti nella decima del 1299.
Di un'antica chiesa di Roccapelago con castello esistente prima del 1205 parla il Tiraboschi, « ma » osserva il Ricci « È la medesima dedicata a S. Maria, che È ricordata nella donazione d'Astolfo, del cui documento si avvale (il Tiraboschi) per la sua notizia ».
Quanto al non figurare Roccapelago nel giuramento prestato a Modena nel 1197, il Ricci ipotizza che il borgo non avesse ancora raggiunta l'autonomia comunale, a differenza di Pievepelago che nel frattempo si era eretta in comune. Lo impediva forse la presenza in loco del feudatario? Può essere, benché in linea di massima i feudatari non ostacolassero la formazione dei comuni. Ma Rocca non tardò a darsi un regime comunale: appena otto anni dopo, infatti, nel 1205, essa figura fra gli altri comuni del Pelago, nella seconda dedizione a Modena. Anche il Santini pensa che le cose siano andate così. « Entrambi (i comuni di Pieve e di Rocca) » egli scrive « compaiono nel 1205 con un solo console, quasi a denunciare una formazione comunale distinta molto recente ».
Passeranno secoli prima che si trovi menzionata la chiesa di Rocca. Essa appare per la prima volta, già parrocchia, nella visita pastorale di Mons. Egidio Foscherari, vescovo di Modena, compiuta il 17 agosto 1552.
La chiesa sorgeva fuori del fortilizio, nella località detta anche oggi S. Polo (S. Paolo). Essendo piccola e angusta, i parrocchiani manifestarono al presule il desiderio di averne una più ampia e decorosa. Il vescovo non potè che apprezzare questo giusto desiderio.
Il parroco era don Antonio di Pietro del luogo. La popolazione ammontava a 600 anime. Vi erano due Compagnie o Confraternite, quella del Corpus Domini (SS. Sacramento) e quella della Madonna.
Di un'antica chiesa di Roccapelago con castello esistente prima del 1205 parla il Tiraboschi, « ma » osserva il Ricci « È la medesima dedicata a S. Maria, che È ricordata nella donazione d'Astolfo, del cui documento si avvale (il Tiraboschi) per la sua notizia ».
Quanto al non figurare Roccapelago nel giuramento prestato a Modena nel 1197, il Ricci ipotizza che il borgo non avesse ancora raggiunta l'autonomia comunale, a differenza di Pievepelago che nel frattempo si era eretta in comune. Lo impediva forse la presenza in loco del feudatario? Può essere, benché in linea di massima i feudatari non ostacolassero la formazione dei comuni. Ma Rocca non tardò a darsi un regime comunale: appena otto anni dopo, infatti, nel 1205, essa figura fra gli altri comuni del Pelago, nella seconda dedizione a Modena. Anche il Santini pensa che le cose siano andate così. « Entrambi (i comuni di Pieve e di Rocca) » egli scrive « compaiono nel 1205 con un solo console, quasi a denunciare una formazione comunale distinta molto recente ».
Passeranno secoli prima che si trovi menzionata la chiesa di Rocca. Essa appare per la prima volta, già parrocchia, nella visita pastorale di Mons. Egidio Foscherari, vescovo di Modena, compiuta il 17 agosto 1552.
La chiesa sorgeva fuori del fortilizio, nella località detta anche oggi S. Polo (S. Paolo). Essendo piccola e angusta, i parrocchiani manifestarono al presule il desiderio di averne una più ampia e decorosa. Il vescovo non potè che apprezzare questo giusto desiderio.
Il parroco era don Antonio di Pietro del luogo. La popolazione ammontava a 600 anime. Vi erano due Compagnie o Confraternite, quella del Corpus Domini (SS. Sacramento) e quella della Madonna.
IL MANIERO DIVENTA CHIESA
Esisteva per gli abitanti di Rocca la possibilità di avere una chiesa ampia e funzionale senza una spesa eccessiva. Il castello d'Obizzo — centro di tante lotte e di tante cupidigie — troneggiava ancora sul suo picco roccioso. Nel 1583, durante la guerra fra gli Estensi e i Lucchesi per il possesso della Garfagnana, si era trasformato in una grande caserma, dove erano affluiti i soldati del Frignano, pronti a marciare oltre il crinale dell Appennino, se gli eventi bellici lo avessero richiesto. Ma ora era deserto e abbandonato. Il tempo aveva sbiadito il ricordo delle gesta terribili e sanguinose che ne avevano intessuto la storia. Le grandi nevicate, i violenti acquazzoni avevano lavato quelle pareti macchiate di sangue, trasudanti crudeltà. Non una profanazione poteva essere, ma una riparazione l'adattamento a oratorio di quelle stanze dove erano risuonate le canzoni oscene e le bestemmie dei soldati avvinazzati, le piaggerie dei cortigiani ipocriti e versipelle, le escandescenze biliose del terribile signore. La presenza del Dio della pace e della mitezza avrebbe santificato quel luogo già impregnato di spirito antievangelico.
E la chiesa sorse, « cappella espiatoria », come la chiama con frase felice Bernardino Ricci. I lavori iniziarono probabilmente nel 1585, ma andarono alquanto a rilento.
La forma quadrata del tempio, senz'archi e senza colonne, « fa credere alla tradizione popolare che il suo vano fosse un dì la sala del castello ». Il locale sottostante, conteneva la cucina con l'immenso camino. La sala, già testimone delle feste e della manifestazioni più importanti della piccola corte, fu ingrandita di due metri dovendosi rifare il muro a nord.
Opera stupenda è il tabernacolo dell'altare maggiore in legno dorato, di stile barocco, « con torrette e nicchie che si equilibrano in bella armonia » (Ricci). Costò 400 scudi (2000 lire modenesi). Lo fece costruire don Giacomo Stefani nel 1603. A questo parroco risale anche il rifacimento del coro e dell'altare maggiore, essendo piccoli e non proporzionati all'ambiente quelli eseguiti in precedenza. Altra pregevole opera artistica, ora scomparsa, era il bel soffitto che il parroco don Francesco Berti fece costruire da Francesco Guglia di Riolunato nel 1728.
La Chiesa è lunga 28 braccia e larga 17. Così il Bianchi. In computo moderno 17 metri, circa, di lunghezza e 10, circa, di larghezza.
L'organo con sette registri risale al 1722 ed è opera del celebre organaro Domenico Traeri. Dapprima era collocato a ridosso della parete interna della facciata, ma, per salvarlo dall'umidità, fu trasportato con la sua tribuna nel presbitero.
Il parroco don Paolo Coppi nel 1868, per abbassare il pavimento della chiesa e renderla più spaziosa, riempì le stanze sottostanti con terra prelevata dal cimitero e in tal modo rese umido il nuovo pavimento in lastre d'ardesia e cancellò un cimelio storico che avrebbe calamitato la curiosità dei visitatori, desiderosi di vedere ciò che restava del celebre castello d'Obizzo.
Il prevosto don Giovanni Biagi dovette far fronte ai gravi danni arrecati al tempio dal terremoto del 7 settembre 1920. I lavori di restauro, cominciati nell'aprile 1925, finirono il 24 dicembre di quell'anno per usufruire del contributo del 75%, concesso dallo Stato.
La chiesa fu rifatta ex-novo per tre quarti. Il muro a nord-ovest venne ricostruito quasi dalle fondamenta. Si sostituì il vecchio ed artistico soffitto del 1728 con un altro meno ricco e pregevole ma più sicuro. Le travi furono acquistate all'Abetone, le tavole di larice a Fiume. Notevoli migliorie furono apportate al coro, alla sagristia, alla tribuna dell'organo. I tre altari del presbitero furono fatti in marmo con una balaustra, essa pure di marmo. Dagli altari posti fuori del presbitero si tolsero le mense che ingombravano il vano della chiesa, per guadagnare spazio.
Il campanile, come c'informa un inventario dei beni della chiesa del 13 agosto 1765, fu eretto « a spese del pubblico ». Contiene quattro campane. La più grossa ha una storia. Era la campana che ritmava la vita del castello prima che Obizzo scrivesse le pagine della sua epopea. Chiamava a raccolta i soldati, suonava a stormo in caso di pericolo, a festa nelle ore liete della piccola corte. Essendosi rotta, fu rifusa nel 1732 dai fratelli Bimbi di Fontanaluccia con l'aggiunta di 22 pesi di bronzo, sicché ora pesa quasi sei quintali. L'adornano alcune figure: l'Annunciazione, le effigi di S. Paolo e di S. Rocco e una Croce. Reca un distico composto dal rettore don Berti: « £.0.0. (Bona omnia ominor) — Salvo defendo doceo fera vulnera curo — Sum maior sed eram bis duo saecla minor — Frane. Berti R. Ant.us et Ioseph Bimbi F.A.D. 1732 ». (« Auspico ogni cosa buona — Salvo difendo ammaestro curo le atroci ferite — Sono la maggiore ma quattro secoli fa ero la minore — Essendo rettore Francesco Berti, fusero Antonio e Giuseppe Bimbi, Vanno del Signore 1732 »).
Esisteva per gli abitanti di Rocca la possibilità di avere una chiesa ampia e funzionale senza una spesa eccessiva. Il castello d'Obizzo — centro di tante lotte e di tante cupidigie — troneggiava ancora sul suo picco roccioso. Nel 1583, durante la guerra fra gli Estensi e i Lucchesi per il possesso della Garfagnana, si era trasformato in una grande caserma, dove erano affluiti i soldati del Frignano, pronti a marciare oltre il crinale dell Appennino, se gli eventi bellici lo avessero richiesto. Ma ora era deserto e abbandonato. Il tempo aveva sbiadito il ricordo delle gesta terribili e sanguinose che ne avevano intessuto la storia. Le grandi nevicate, i violenti acquazzoni avevano lavato quelle pareti macchiate di sangue, trasudanti crudeltà. Non una profanazione poteva essere, ma una riparazione l'adattamento a oratorio di quelle stanze dove erano risuonate le canzoni oscene e le bestemmie dei soldati avvinazzati, le piaggerie dei cortigiani ipocriti e versipelle, le escandescenze biliose del terribile signore. La presenza del Dio della pace e della mitezza avrebbe santificato quel luogo già impregnato di spirito antievangelico.
E la chiesa sorse, « cappella espiatoria », come la chiama con frase felice Bernardino Ricci. I lavori iniziarono probabilmente nel 1585, ma andarono alquanto a rilento.
La forma quadrata del tempio, senz'archi e senza colonne, « fa credere alla tradizione popolare che il suo vano fosse un dì la sala del castello ». Il locale sottostante, conteneva la cucina con l'immenso camino. La sala, già testimone delle feste e della manifestazioni più importanti della piccola corte, fu ingrandita di due metri dovendosi rifare il muro a nord.
Opera stupenda è il tabernacolo dell'altare maggiore in legno dorato, di stile barocco, « con torrette e nicchie che si equilibrano in bella armonia » (Ricci). Costò 400 scudi (2000 lire modenesi). Lo fece costruire don Giacomo Stefani nel 1603. A questo parroco risale anche il rifacimento del coro e dell'altare maggiore, essendo piccoli e non proporzionati all'ambiente quelli eseguiti in precedenza. Altra pregevole opera artistica, ora scomparsa, era il bel soffitto che il parroco don Francesco Berti fece costruire da Francesco Guglia di Riolunato nel 1728.
La Chiesa è lunga 28 braccia e larga 17. Così il Bianchi. In computo moderno 17 metri, circa, di lunghezza e 10, circa, di larghezza.
L'organo con sette registri risale al 1722 ed è opera del celebre organaro Domenico Traeri. Dapprima era collocato a ridosso della parete interna della facciata, ma, per salvarlo dall'umidità, fu trasportato con la sua tribuna nel presbitero.
Il parroco don Paolo Coppi nel 1868, per abbassare il pavimento della chiesa e renderla più spaziosa, riempì le stanze sottostanti con terra prelevata dal cimitero e in tal modo rese umido il nuovo pavimento in lastre d'ardesia e cancellò un cimelio storico che avrebbe calamitato la curiosità dei visitatori, desiderosi di vedere ciò che restava del celebre castello d'Obizzo.
Il prevosto don Giovanni Biagi dovette far fronte ai gravi danni arrecati al tempio dal terremoto del 7 settembre 1920. I lavori di restauro, cominciati nell'aprile 1925, finirono il 24 dicembre di quell'anno per usufruire del contributo del 75%, concesso dallo Stato.
La chiesa fu rifatta ex-novo per tre quarti. Il muro a nord-ovest venne ricostruito quasi dalle fondamenta. Si sostituì il vecchio ed artistico soffitto del 1728 con un altro meno ricco e pregevole ma più sicuro. Le travi furono acquistate all'Abetone, le tavole di larice a Fiume. Notevoli migliorie furono apportate al coro, alla sagristia, alla tribuna dell'organo. I tre altari del presbitero furono fatti in marmo con una balaustra, essa pure di marmo. Dagli altari posti fuori del presbitero si tolsero le mense che ingombravano il vano della chiesa, per guadagnare spazio.
Il campanile, come c'informa un inventario dei beni della chiesa del 13 agosto 1765, fu eretto « a spese del pubblico ». Contiene quattro campane. La più grossa ha una storia. Era la campana che ritmava la vita del castello prima che Obizzo scrivesse le pagine della sua epopea. Chiamava a raccolta i soldati, suonava a stormo in caso di pericolo, a festa nelle ore liete della piccola corte. Essendosi rotta, fu rifusa nel 1732 dai fratelli Bimbi di Fontanaluccia con l'aggiunta di 22 pesi di bronzo, sicché ora pesa quasi sei quintali. L'adornano alcune figure: l'Annunciazione, le effigi di S. Paolo e di S. Rocco e una Croce. Reca un distico composto dal rettore don Berti: « £.0.0. (Bona omnia ominor) — Salvo defendo doceo fera vulnera curo — Sum maior sed eram bis duo saecla minor — Frane. Berti R. Ant.us et Ioseph Bimbi F.A.D. 1732 ». (« Auspico ogni cosa buona — Salvo difendo ammaestro curo le atroci ferite — Sono la maggiore ma quattro secoli fa ero la minore — Essendo rettore Francesco Berti, fusero Antonio e Giuseppe Bimbi, Vanno del Signore 1732 »).